Continua inesorabile il calo delle nascite in Italia
L’aggiornamento Istat su Natalità e fecondità della popolazione residente in Italia per l’anno 2024, fornisce una proiezione provvisoria per i primi mesi del 2025, evidenziando un quadro di natalità in forte declino e di fecondità molto bassa.
La dinamica generale mostra una continuità del trend avviato nel 2008: nascite in rallentamento, con livelli medi di figli per donna ai minimi storici, e una popolazione di potenziali genitori sempre più ridotta dalle generazioni nate dal 1970 in poi.
Il 2024 conferma una fase strutturale di declino demografico: fecondità storicamente bassa, primo figlio sempre meno diffuso e una dinamica migratoria interna che contribuisce a una composizione familiare più complessa. Le condizioni economiche, lavorative e abitative continuano a influire pesantemente sulle scelte di genitorialità, con effetti prevedibili sul sistema di servizi sociali, sanitario e sui piani di sviluppo a lungo termine della popolazione residente. Se questo è vero per tutti, gli effetti si fanno sentire maggiormente per gli esercenti le professioni infermieristiche, gravati anche dalle conseguenze dei turni cui sono sottoposti.
I dati
Nel 2024 le nascite sono state 369.944, in calo di circa 10.000 unità rispetto all’anno precedente (-2,6%). Il numero medio di figli per donna si è attestato a 1,18, scendendo dal 1,20 del 2023. La proiezione relativa ai primi sette mesi del 2025 indica una fecondità pari a 1,13 e una continuazione della tendenza al ribasso. Il tasso di natalità 2024 si è fermato a 6,3 nati per mille residenti, contro i 9,7 per mille del 2008.
La riduzione delle nascite prosegue senza soste dal 2008, anno di massimo storico per il secolo, con un deficit cumulato di oltre 207.000 nati, pari a una perdita del 35,8%. Un fattore chiave è la diminuzione delle nascite da coppie di genitori entrambi italiani, che hanno fornito oltre il 78% delle nascite totali ma mostrano un calo marcato: -3,3% rispetto al 2023, con 289.183 nati. Le nascite da coorti con almeno un genitore straniero restano sostanzialmente stabili (-0,2% rispetto al 2023), totalizzando 80.761 nati nel 2024, pari al 21,8% del totale. Le nascite da coppie miste rappresentano l’8,1% del totale (30.168 nati), con crescite lievi rispetto all’anno precedente.
La distribuzione territoriale rivela una contrazione diffusa, ma con intensità diversa. Il Mezzogiorno mostra il calo più marcato nei primogeniti (-4,3%), seguito dal Centro (-2,0%) e dal Nord (-1,8%). Anche per i figli di ordine successivo la riduzione è più evidente nel Mezzogiorno (-4,3%). Questi pattern riflettono difficoltà comuni nell’uscita dal nucleo familiare di origine, legate a tempi di formazione prolungati, precarietà del lavoro giovanile e difficoltà di accesso alla casa di proprietà, fattori che favoriscono il rinvio o la rinuncia alla genitorialità.
La quota di nascite da coppie con almeno un genitore straniero resta stabile: nel 2024 costituiscono il 21,8% del totale, pari a 80.761 nati, rispetto ai 80.942 del 2023. I nati da coppie miste rappresentano l’8,1% del totale, con un +2,3% sul 2023. I nati da genitori entrambi stranieri si mantengono al 13,7% del totale, pari a 50.593 (in lieve calo dell’1,7%). Sul piano territoriale, la quota di nati con almeno un genitore straniero è maggiore nel Centro-Nord(30,6% nel Nord, 24% nel Centro, 9,3% nel Mezzogiorno), riflettendo una penetrazione straniera geograficamente diversa.
Analizzando le specifiche cittadinanze, i nati da almeno un genitore straniero hanno come principali gruppi di riferimento rumeno, marocchino e albanese (in ordine di incidenza complessiva). Circa il 60% dei genitori tra queste coppie sono entrambi stranieri, mentre circa il 40% sono in coppia mista. Per quanto riguarda le dinamiche tra i due genitori stranieri, la quota è maggiore per chi ha padre straniero e madre italiana (+4,5%) e per chi ha madre straniera in coppia mista (+1,3%).
Guardando al 2025, i primi sette mesi mostrano una continuità del trend di denatalità su base mensile, con Abruzzo e Sardegna tra le regioni più colpite e la Valle d’Aosta e le Province autonome di Bolzano e Trento tra le poche a registrare crescite, sebbene in percentuali contenute. Le regioni del Centro e del Mezzogiorno mostrano le diminuzioni più marcate rispetto al Nord, evidenziando una geografia della fertilità ancora molto eterogenea.
Andrea Tirotto


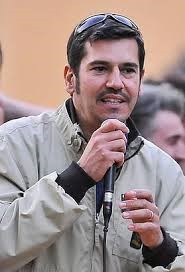 di
di